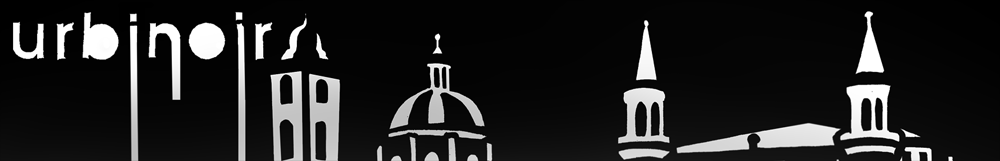BUON COMPLEANNO, SONERI !
IL COMMISSARIO SONERI COMPIE… DIECI ANNI !
AUGURI E… CENTO DI QUESTI ROMANZI !
Bersaglio l’oblio 2000 (Diabasis)
Il cineclub del mistero 2002 (Passigli)
Il Fiume delle nebbie 2003 (Frassinelli)
L’Affittacamere 2004
Le Ombre di Montelupo 2005
A mani vuote 2006
Oro, incenso e polvere 2007
La casa del comandante 2008
Il commissario Soneri e la mano di Dio 2009
E’ solo l’inizio, commissario Soneri 2010
Intervista tratta dalla presentazione di E’ solo l’inizio, commissario Soneri
Durante la prima parte Marco Bertozzi, docente di Filosofia all’Università di Ferrara, presenta l’autore e dialoga con lui sul nuovo romanzo. Ricorda che il titolo si ispira al Maggio francese, descrive gli scenari nebbiosi che fanno da sfondo al romanzo e l’improvvisa “luce” della Ligura, quasi una metafora del percorso dell’indagine, e illustra il “metodo” di Soneri, più legato all’induzione e all’intuizione che non al ragionamento logico-deduttivo.
Nella seconda parte Alessandra Calanchi rende omaggio ai “10 anni” di Soneri e si concentra sulla scelta narrativa della serializzazione e sui “vuoti di memoria” che Varesi cerca di colmare nei suoi romanzi.
In questa mia presentazione ho deciso di rivolgermi più al personaggio, Soneri, che al suo autore, Valerio Varesi. Mi sembra infatti giunto il momento di dedicare qualche parola ufficiale al personaggio piuttosto che al suo autore, perché siamo già arrivati al decimo Soneri in un arco di 10 anni e dobbiamo festeggiare questo anniversario importante. Per fare un paragone, Conan Doyle scrisse solo 4 romanzi (e 56 racconti brevi) in 40 anni (dal 1887 al 1927) dunque Soneri è sulla buona strada…
Anche il mio abbigliamento è un omaggio a Soneri: il grigio è il colore della nebbia, e la nebbia – che ritroviamo spesso nei suoi romanzi e nelle serie tv – rappresenta un indizio geografico e mentale importante, diventa quasi – come nei romanzi inglesi di tardo 800 – un cronotopo esistenziale, non solo uno sfondo o un dettaglio meteorologico ma una strategia narrativa e un condizione dell’anima. Insomma, Soneri è un uomo nebbioso… più grigio che noir, si muove con modestia e discrezioni fra scene del crimine attutite dai vapori del Po, nella bassa, o dalla neve che scende fitta sul primo Appennino…
Innanzitutto esiste una lunga e nobile tradizione del romanzo seriale. E’ un vero e proprio genere letterario, nato all’alba dell’epoca della cultura di massa, l’epoca del feuilleton, del romanzo d’appendice, della narrativa sensazionale. Inizialmente strutturato a puntate sulle riviste, il romanzo seriale diventa presto prodotto autonomo e questo sancisce tre fatti fondamentali:
1-l’eroe della narrativa popolare è salito a tutti gli effetti sullo stesso piano dell’eroe della tragedia classica o dell’epopea, come Edipo, o Odisseo, eroi che nell’età antica tornavano in più narrazioni. Sarà questa, ricordiamolo, anche la base del fumetto, il genere letterario in cui più di ogni altro genere si concretizza quello che Eliade definì “il mito dell’eterno ritorno”;
2-il rapporto fra autore e pubblico non potrà più essere quello di prima: i lettori iniziano a scrivere lettere, dialogare, chiedere, ecc. Nasce la fandom e nasce un patto implicito tra autore e fandom: io continuo a scrivere e voi continuate a leggere;
3-in questo patto l’autore cede un pezzetto della propria notorietà al suo personaggio, che rischia di diventare più famoso dell’autore stesso (vedi il caso di Sherlock Holmes).
Inoltre la serializzazione richiede due elementi sine qua non:
1-uno o più elementi di originalità che distinguano il protagonista da altri – nel caso di Soneri potremmo dire il mood malinconico, il coinvolgimento emotivo con il criminale, e la presenza di un mondo di “vinti” (per es. i pescatori) di statura quasi verghiana; la “simpatia” che prova Soneri non è noir, non è cioè la scoperta di una sua dark side come avviene appunto nel noir o nell’horror, pensiamo a Berselli o Nerozzi. La sua “simpatia” semmai è la consapevolezza di un grey side, una comunione di malesseri, una condivisione di umanità;
2-uno o più elementi di continuità e riconoscibilità – nel caso di Soneri il sigaro, la presenza di Angela, l’amore per il cibo, il fatto che viene sempre chiamato per cognome, ecc. Varesi dimostra con questi dieci romanzi di essere un ottimo rappresentante del genere e di aver trovato una sua identità sia rispetto agli investigatori “storici” (Holmes, Maigret…) sia rispetto agli altri investigatori italiani (Sarti Antonio di Macchiavelli, Montalbano di Camilleri, ecc.)
E ora un paio di domande…
AC
Tutti gli autori che decidono di scrivere romanzi seriali sperimentano a un certo punto della loro carriera una vicinanza quasi invadente della loro “creatura”… Succede qualche volta anche a Varesi di sentirsi sovrapposto o confuso con Soneri? Gli succede mai di pensare con i pensieri di Soneri? E – ultima domanda – gli succede mai di volersi liberare di Soneri, così come Conan Doyle a più riprese cercò di liberarsi di Sherlock Holmes?
VV
No ma desidero essere conosciuto anche per le altre cose che scrivo… innanzitutto sono anche giornalista, poi i miei romanzi hanno dei contenuti sociali, al di là di Soneri… per questo a volte non ho specificato nei titoli che si trattava della serie con il “commissario Soneri”… In più sì, in verità comincio a essere un po’ geloso di Soneri.
AC
In una recensione de La casa del comandante si legge “Varesi ha uno zoccolo duro di affezionati che gli scrivono per chiedere conto del Soneri di carta, ‘ma di quello del piccolo schermo no […]’ ”.
Esiste, o potrebbe esistere, un “Soneri fan club” ? qual è il tuo rapporto con i lettori? In quale misura interagiscono con te e con le tue scelte?
VV
Beh so che c’è un Valerio Varesi fan club … e poi ho 1500 “amici” su FaceBook … incredibile … ma vado anche molto in giro a presentare i miei libri, a parlare, mi piace incontrare le persone e con i miei lettori ho un ottimo rapporto
Leggendo le recensioni dei romanzi di Varesi si ha l’impressione che la cifra della sua scrittura sia da ricercarsi soprattutto nelle descrizioni geografiche (il parmense e la Liguria, le piene del Po) e nelle suggestioni metereologiche (la nebbia, la neve, la pioggia). In realtà, io personalmente ci ritrovo molto più la storia, e parlo della nostra storia recente, quella che inizia a metà del 900. E’ una storia recente ma che viene sistematicamente messa in secondo piano rispetto ai fasti della Roma imperiale o alle azioni degli eroi risorgimentali. E’ la storia di cui parla ad esempio Stefano Pivato nel suo libro Vuoti di memoria (2007), un libro che ci ricorda la responsabilità della memoria individuale e collettiva e la troppa frequente amnesia da cui siamo affetti – nulla di nuovo visto che Pasolini scriveva “Noi siamo un paese senza memoria. Il che equivale a dire senza storia. L’Italia rimuove il suo passato prossimo, lo perde nell’oblio dell’etere televisivo” (Scritti corsari, 1975).
Non sono l’unica a pensarla così. Leggo da una recensione de Il fiume delle nebbie: “storia dopo storia, pagina dopo pagina, la figura del Commissario Soneri si delinea precisa, in mezzo a quella di tanti illustri ‘colleghi’ e modelli letterari: ma tra i tanti forse si distingue per la robusta simpatia verso tutto ciò che fa parte di un passato prossimo, vivo ormai solo nella memoria di alcuni inguaribili romantici, e per quella malinconica tolleranza con cui si adatta e si destreggia, suo malgrado, tra losche vicende anche troppo moderne.”
Mi sembra che Varesi, puntualmente, in ogni suo romanzo, affronti anche se in prospettiva laterale momenti storici o tematiche sociali cruciali: per fare qualche esempio, ne L’affittacamere gli aborti clandestini, ne Le ombre di Montelupo il caso Parmalat, ne La casa del comandante la guerra partigiana, nell’ultimo romanzo il Sessantotto…
E’ chiaro che i delitti e l’indagine sono prioritari rispetto al subplot storico, ma credo che Varesi svolga un’importante azione di ripresa di temi che rischiano di essere dimenticati, sottostimati, e che invece sotto il suo sguardo riprendono vita e vengono anche rimessi in discussione.
A questo proposito: mentre ne La casa del comandante Varesi si spingeva a esprimere considerazioni molto forti ed esplicite sull’attuale situazione politica – “Se i delinquenti possono governare, anch’io posso agire come mi pare (p. 262) […] Come si fa a condannare un ladro se chi ci governa è lui stesso un ladro? (p. 264) […] Lei [Soneri] sorveglia e loro [i governanti] rubano, affamano, distruggono, calpestano le leggi che fabbricano facendole però valere per i sudditi” (p. 276)” – in quest’ultimo i toni sono molto più soffusi, più esistenziali che sociopolitici… tranne una denuncia esplicita dei danni del liberismo economico (“C’è toccato di veder nascere il crimine del liberismo economico e contare le sue macerie”, p. 131), l’amarezza sembra rivolta soprattutto alla generazione dei 68ini che “si sono presi tutto” … e che vengono definiti “Che Guevara da tinello”… niente a che vedere con l’alta figura morale dei vecchi partigiani… “Quelli del Sessantotto hanno divorato quasi tutto e a noi sono rimasti gli avanzi […] La nostra generazione non ha alzato la voce, non è stata mai protagonista … E’ passata scalza e a testa bassa attraversando il tempo (p. 69)
Ma ci sono anche dichiarazioni più “esistenziali”, per esempio: “Il giorno in cui le persone parleranno solo quando avranno qualcosa da dire, sul mondo calerà un grande silenzio” – p. 2 (Soneri), oppure questa: “siamo fatti di niente” – p. 20 (Soneri), che però attenzione: pare una citazione shakespeariana ma ha qualche suggestione hard-boiled, sembra tratta da Il falcone maltese… e anche la frase “ancora una volta lo salvò il cellulare: uno squillo liberatorio come il gong per un pugile alle corde” – p. 42 (Soneri) sembra uscita da un romanzo di Hammett (se non fosse per il cellulare…) E’ senz’altro vero, come dice Bertozzi, che Soneri non è un uomo d’azione, e che la sua “malinconia” (e Bertozzi autore de Il detective malinconico è un’autorità in materia) lo accomuna a Holmes (che soffre per la dull routine of existence) ma ricordiamo che anche i “duri” americani hanno una fragilità intrinseca, una sorta di nostalgia, di malinconia che si portano dentro (penso ai romanzi di Chandler ma anche a film come Le catene della colpa, Vertigine, La fiamma del peccato).
(a.c.)